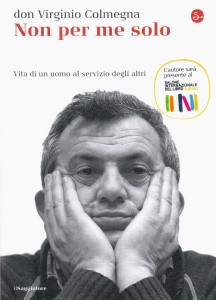Vita di un uomo al servizio degli altri. – Il Saggiatore (2011)
Il volume “Non per me solo. Vita di un uomo al servizio degli altri” già nel titolo e nel sottotitolo si presenta come una autobiografia biografica, proprio perché le vite degli altri sono essenziali per raccontare la vita del protagonista. Anzi si potrebbe pensare che gli altri sono i protagonisti e che chi scrive ambisca ad essere tutt’al più un coprotagonista.
“La mia sola voce non basta (…) ho bisogno che gli altri raccontino la loro storia per aiutarmi a capire più a fondo la mia.”
Don Virginio Colmegna, infatti, -e non casualmente il Don precede il nome dell’autore, visto che la stessa autobiografia prende le mosse dall’emergere della sua vocazione e dalla determinazione a diventare sacerdote a soli 14 anni- appare incapace di tracciare il proprio percorso di vita senza fare ricorso all’apporto indispensabile degli altri.
Se qualcuno pensasse ad un espediente per sottrarsi alle fatiche di uno sguardo centrato su di sé ed introspettivo, si ricrederebbe ben presto procedendo nella lettura, perché i riferimenti al proprio processo di crescita sono costanti.
“Sono piuttosto una <testa dura>, lo sono sempre stato.”
“(…) a scuola prendevo posizione e mi esponevo cercando il confronto serrato, le parole persuasive, la verifica continua.”
“(…) ringrazio di queste opportunità formative, che allora quasi mi sembrava di accatastare dentro di me come pezzi sconnessi”; ma anche “In quel periodo imparavo a tenere dentro di me poli a volte opposti e a lasciarli dialogare.”
Queste brevi citazioni, accanto ad un essenziale emergere della triade familiare guidata dalla madre “(…) donna assorbita dal lavoro, e con una responsabilità familiare precisa: un figlio minorenne e un marito invalido”, benché “l’invalido più attivo che conoscessi”, tracciano l’avvio di un percorso.
E culminano con una affermazione efficacissima, che tecnicamente si potrebbe definire ‘empowered oriented’ e votata alla valorizzazione dell’esistente: “ (…) la vocazione mi permette (…) di vedere ciò che c’è prima di ciò che ancora manca.”
Se i primi due capitoli sono preliminari e cioè dedicati alla formazione e vocazione di Don Colmegna nel senso prima indicato, i successivi cinque capitoli rappresentano in pratica le sue ‘opere’, articolate nelle diverse ‘opere-segno’ promosse costantemente come sintesi di pensiero e azione.
Dall’avventura della scuola popolare, l’insegnamento della religione e il successivo licenziamento nell’esperienza di prete alla Bovisa nel vortice del ’68 all’interrogarsi negli anni successivi su come servire, le riflessioni sull’essere ‘prete-operaio’ e l’incontro determinante con il vescovo Carlo Maria Martini, foriero di gran parte degli importanti impegni successivi che Don Colmegna assumerà.
Dalla prima esperienza di parroco a Sesto San Giovanni con l’esperienza della Comunità per disabili Parpagliona dalla quale si diffondono altre comunità anche per minori, cooperative, consorzi, unitamente all’assunzione della vicepresidenza del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, alla esperienza di diversi anni come direttore della Caritas ambrosiana, gli impegni nella ‘pedagogia dell’adulto’, nella psichiatria di strada e sul fronte internazionale ed in contemporanea eventi strettamente personali e sofferti come la morte della madre prima e del padre poi.
Ed infine la Casa della Carità, ultima sua opera, dalla quale scrive questa autobiografia ed alla quale devolve i proventi di quest’opera.
Avviata nel 2002 ed inaugurata nel 2004 sulla base di un’importante eredità e su input di Carlo Maria Martini, la Casa della Carità viene affidata all’autore con l’indicazione di mantenere una ospitalità gratuita, per gli ultimi fra gli ultimi.
Don Colmegna accoglie l’incarico delineando tre direttrici fondamentali: “Abitare il territorio metropolitano, stare in mezzo alle contraddizioni e alle fatiche della gente, ricevere e suscitare cultura.” Con cantieri riflessivi (pensiero) e cantieri operativi (azione) si delinea un’opera di accoglienza ed ospitalità che vede la presenza contemporanea di un centinaio e più persone ospitate, ma che in sette anni è stata abitata da migliaia di persone di tutte le nazionalità.
Nell’unica poesia dell’autore riportata nel testo e dedicata a Sergio, giovane di straordinaria intelligenza, affetto da tetraparesi spastica e che si diceva non credente, vinto infine dalla malattia, Don Virginio Colmegna sembra riassumere, nel finale, il senso ultimo del suo sforzo autobiografico:
“ (…)
Eppure avete vissuto,
avete dato
il senso alla nostra vita,
grazie.”
Che sembra tenere insieme l’autore e tutti gli altri in un abbraccio sincero. (G.M.)